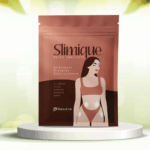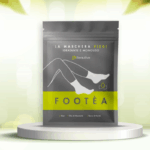La questione della sicurezza dei dolcificanti artificiali è tornata prepotentemente al centro dell’attenzione dopo la recente classificazione da parte della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) di alcuni composti comunemente utilizzati nell’industria alimentare. I dolcificanti sono dappertutto: dalle bevande leggere fino ai chewing gum, dai prodotti caseari alle caramelle, e la loro popolarità cresce in una società sempre più attenta a ridurre il consumo di zucchero. Tuttavia, emergono timori su alcuni di questi additivi, sospettati di poter contribuire allo sviluppo di tumori in determinate condizioni. Analizziamo quali sono i dolcificanti posti sotto sorveglianza, quali sono i rischi potenzialmente associati e la posizione attuale delle autorità sanitarie internazionali.
I dolcificanti sotto sospetto secondo le ultime evidenze scientifiche
L’attenzione degli esperti e degli organismi di controllo si è concentrata in particolare su aspartame, acesulfame-K, saccharina, sucralosio e ciclammati. Questi dolcificanti, spesso impiegati come sostituti a basso o nullo contenuto calorico, sono stati oggetto di studi epidemiologici e sperimentali che ne hanno indagato la cancerogenicità potenziale:
- Aspartame: È attualmente classificato dalla IARC come “possibilmente cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 2B). Ciò significa che esistono prove limitate nell’uomo e qualche riscontro negli animali circa una possibile associazione tra assunzione elevata e sviluppo di alcuni tipi di tumore, in particolare tumori al fegato e tumori ematologici. Tuttavia, la comunità scientifica sottolinea che le prove non sono sufficienti per stabilire una relazione causale certa e che il rischio dipende fortemente dal dosaggio e dalla durata del consumo.
- Acesulfame-K: Alcuni studi hanno suggerito un rischio potenzialmente simile a quello dell’aspartame, soprattutto per tumori legati all’obesità e al tumore al seno. L’acesulfame-K è oggetto di monitoraggio costante da parte delle autorità e viene raccomandata moderazione nel consumo.
- Saccharina e sucralosio: Storicamente controversi, devono la loro reputazione a risultati discordanti tra vecchi e nuovi studi. Recenti investigazioni suggeriscono che possano indurre danni al DNA, con potenziale incremento del rischio di insorgenza tumorale, benché ad oggi nessuna organizzazione internazionale li classifichi come cancerogeni conclamati. Il consumo prolungato e ad alte dosi è comunque sconsigliato.
- Ciclammati: Vietati negli Stati Uniti ma ancora usati in alcuni paesi europei, i ciclammati sono stati indagati in passato per sospetta cancerogenicità. Attualmente, i dati non confermano un rischio certo, ma il principio di precauzione rimane una guida nelle politiche di regolamentazione.
- Stevia (Rebaudioside A): Estratta da una pianta e considerata di origine naturale, finora nessuno studio ha evidenziato rischi cancerogeni associati al suo consumo regolare alle dosi quotidiane raccomandate.
Meccanismi biologici: come agiscono i dolcificanti sospettati
Per comprendere le ragioni dell’allarme, è importante approfondire quali meccanismi biologici ricollegano i dolcificanti artificiali ai processi tumorali. L’aspartame, ad esempio, viene metabolizzato nel corpo umano in fenilalanina, acido aspartico e metanolo. Proprio il metanolo può trasformarsi a sua volta in formaldeide, composta riconosciuta come cancerogena per l’uomo. Alcune ricerche suggeriscono che l’aspartame possa inibire i geni protettivi responsabili dell’autodistruzione delle cellule diventate cancerose, compromettendo così le naturali difese dell’organismo.
Inoltre, è stato dimostrato che dolcificanti come sucralosio e saccharina sono in grado di indurre danni al materiale genetico (DNA), peggiorando il potenziale rischio di trasformazione tumorale delle cellule. Ma non solo: un pericolo più subdolo riguarda i profondi effetti sul microbiota intestinale. Modificare l’equilibrio dei batteri intestinali può indebolire il sistema immunitario e ridurre la capacità di individuare ed eliminare potenziali cellule cancerose.
L’attuale posizione delle autorità sanitarie e il principio di precauzione
La valutazione della cancerogenicità di una sostanza segue una precisa metodologia, basata su studi epidemiologici sull’uomo, sperimentali sugli animali e indagini di laboratorio. Nel luglio 2024 la IARC, agenzia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ufficialmente inserito l’aspartame in Gruppo 2B: “possibilmente cancerogeno per l’uomo”. Ciò non significa che vi sia certezza di un effetto tumorigeno, ma che esistono prove sufficienti negli animali da esperimento e limitate negli esseri umani. Molte autorità, tra cui la Commissione Europea e l’EFSA, sottolineano però che le quantità normalmente assunte con una dieta bilanciata rientrano nelle dosi accettabili di sicurezza, fissate a 40 mg per kg di peso corporeo al giorno per l’aspartame. Solo in caso di assunzioni ripetute e sostenute negli anni i rischi potrebbero concretizzarsi.
L’attenzione resta però alta. Richieste di divieto o limitazione dell’uso industriale degli edulcoranti sospetti si moltiplicano: associazioni di consumatori, organizzazioni contro il cancro e app di analisi alimentare come Yuka hanno promosso petizioni per spingere la politica verso una maggiore prudenza. Allo stesso tempo, la comunità scientifica invoca nuovi e più approfonditi studi, soprattutto per comprendere la reale portata del potenziale rischio nell’uomo rispetto agli animali e definire meglio le soglie di sicurezza.
Consigli pratici e prospettive future per i consumatori
Restare informati è il primo passo per una scelta consapevole. Ecco alcuni suggerimenti utili per consumatori e famiglie:
- Preferire il consumo di alimenti freschi e poco trasformati, limitando quelli industriali che contengono dolcificanti aggiunti.
- Leggere sempre l’etichetta ingredienti: l’aspartame è indicato dal codice E951, l’acesulfame-K come E950, la saccharina come E954, il sucralosio come E955 e i ciclammati come E952.
- Non eccedere nell’assunzione, prestando attenzione agli alimenti “light” e alle bevande zero calorie, spesso fonti “nascoste” di edulcoranti.
- Per gli individui con predisposizione genetica o storia familiare di tumori, è raccomandata una maggiore prudenza.
- L’estratto di stevia è considerato sicuro, a patto che non venga assunto in dosi superiori a quelle giornaliere consigliate.
Guardando al futuro, la ricerca dovrà chiarire se e in quale misura i dolcificanti artificiali rappresentino un rischio concreto per la salute pubblica. La trasparenza delle autorità, l’aggiornamento costante delle normative e l’educazione alimentare dei cittadini rimangono fondamentali per una tutela efficace. Fino a quando la scienza non avrà a disposizione dati definitivi, il principio di precauzione resta la migliore strategia: evitare eccessi e alternare preferibilmente zuccheri naturali e dolcificanti di origine vegetale, sempre sotto la supervisione di professionisti della salute e all’interno di uno stile di vita sano.