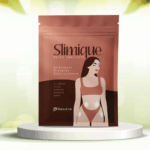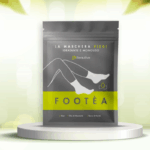L’acqua che sgorga dai nostri rubinetti rappresenta la principale fonte di idratazione quotidiana per milioni di persone, ma spesso viene trascurata la reale composizione chimica di ciò che beviamo e il complesso sistema di trattamenti a cui viene sottoposta per garantirne la sicurezza. Se da un lato l’acqua del rubinetto contiene preziosi minerali essenziali per il nostro organismo, dall’altro è sottoposta a processi di disinfezione chimica che introducono una serie di sostanze necessarie per eliminare i rischi batterici e virali. Comprendere queste dinamiche è essenziale per valutare con consapevolezza la qualità dell’acqua che consumiamo ogni giorno.
I principali agenti chimici usati per la disinfezione
La disinfezione dell’acqua potabile rappresenta una tappa obbligata nei processi di potabilizzazione moderni. Le aziende idriche ricorrono prevalentemente a sostanze chimiche capaci di neutralizzare virus, batteri, protozoi e altri agenti patogeni, senza però lasciare residui dannosi per la salute umana. Tra i disinfettanti chimici più diffusi figurano:
- Cloro: È senz’altro il protagonista assoluto nelle acque del rubinetto. Viene utilizzato sotto forma di gas, ipoclorito di sodio o di calcio. La sua efficacia è dovuta alla capacità di distruggere microrganismi patogeni, pur lasciando spesso un tipico odore o sapore. Il cloro continua ad agire anche nelle tubature, offrendo una protezione residua fino al punto di utilizzo finale.
- Diossido di cloro: Alternativo al cloro tradizionale, risulta meno incline a produrre sottoprodotti potenzialmente tossici e viene impiegato soprattutto in impianti di grandi dimensioni.
- Ipoclorito: Derivato del cloro, impiegato per la sua rapidità di azione soprattutto nei piccoli impianti.
- Ozono: Un potente ossidante naturale, usato per neutralizzare anche i patogeni più resistenti. L’ozono si degrada rapidamente in ossigeno e non lascia residui chimici, tanto da essere considerato uno dei metodi più “puliti” di disinfezione.
Talvolta si fa uso anche di processi fisici come i raggi ultravioletti (UV), soprattutto nei piccoli acquedotti, ma le sostanze chimiche rimangono i principali alleati per una disinfezione capillare e sicura.
Sostanze aggiunte e sottoprodotti della disinfezione
Laddove le sostanze chimiche impiegate risultano efficaci nel neutralizzare i microrganismi, è inevitabile la formazione di sottoprodotti della disinfezione (DBP, Disinfection By Products). Questi composti si formano dalla reazione tra il disinfettante e la materia organica presente nell’acqua. Nel caso del cloro, tra i principali sottoprodotti troviamo i trialometani (come il cloroformio), alcuni dei quali sono monitorati dalle autorità sanitarie per il possibile effetto nocivo a lungo termine. Va sottolineato tuttavia che i limiti imposti dalla normativa italiana e dalla Direttiva europea sono tra i più severi al mondo, tenendo conto dei rischi cumulativi e fissando soglie massime per ogni sostanza.
Oltre agli agenti disinfettanti e ai loro sottoprodotti, l’acqua del rubinetto può contenere numerosi minerali (tra cui calcio, magnesio, sodio, potassio) e una varietà di oligoelementi. Questi sono in gran parte innocui e spesso benefici, poiché derivano dal naturale percorso dell’acqua attraverso rocce e terreni nel ciclo idrologico.
Contaminanti di origine industriale e limiti di legge
Nonostante i trattamenti di potabilizzazione, nel sistema idrico possono accidentalmente penetrare contaminanti di origine industriale o agricola come metalli pesanti (piombo, rame, mercurio, nichel, cromo, cadmio), nitrati e nitriti, PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), pesticidi e microplastiche. I valori di questi inquinanti sono rigidamente regolamentati; solo per i metalli pesanti, la legislazione europea ha fissato 65 parametri chimici e microbiologici per garantire la massima tutela della salute dei cittadini.
I limiti più rilevanti includono:
- Antimonio: 0,005 mg/L
- Arsenico: 0,01 mg/L
- Bario: 1 mg/L
- Borato: 1 mg/L
- Cadmio: 0,003 mg/L
- Cromo: 0,05 mg/L
- Rame: 1 mg/L
- Piombo: 0,01 mg/L
- Mercurio: 0,001 mg/L
- Nitrato: 50 mg/L
- Nitrito: 0,1 mg/L
- PFAS: valori specifici per singoli composti come PFOA e PFOS
Di particolare preoccupazione sono i PFAS: secondo recenti indagini, la loro presenza è stata riscontrata nel 79% dei campioni di acqua pubblica in Italia, con potenziali rischi per sistema endocrino, immunitario, fegato, tiroide e fertilità. Questi contaminanti, usati in molti processi industriali e prodotti di consumo, sono particolarmente persistenti in ambiente e difficili da eliminare.
Benefici e rischi: un bilancio per il consumatore
È indubbio che la disinfezione chimica dell’acqua porti enormi benefici in termini di riduzione delle malattie infettive e di sicurezza sanitaria generale. A prova di ciò, l’introduzione del cloro nel trattamento pubblico delle acque nel XX secolo è stata una delle più efficaci misure di sanità pubblica nella storia, abbattendo paraisitismi e mortalità dovuti a colera, tifo ed epatite. Inoltre la presenza di minerali naturali come il calcio e il magnesio, utili per la salute ossea e per il metabolismo, è generalmente considerata un vantaggio rispetto ad acque troppo purificate o demineralizzate.
Esistono però rischi da non trascurare. L’esposizione cronica a basse dosi di sottoprodotti della disinfezione o a contaminanti come i PFAS è oggetto di continui studi scientifici, e richiede la costante vigilanza delle autorità sanitarie. In alcune zone particolarmente colpite da attività industriali o agricole, le concentrazioni di alcuni inquinanti possono raggiungere valori di attenzione, rendendo opportuno l’uso di filtri domestici o la preferenza per l’acqua in bottiglia per specifiche categorie di persone vulnerabili.
La legislazione europea e italiana garantisce comunque un altissimo grado di controllo e analisi, con monitoraggi giornalieri e pubblicazione obbligatoria dei risultati. Un’inchiesta giornalistica recente ha dimostrato che in molti casi l’acqua del rubinetto, rispetto a quella in bottiglia, rispetta parametri qualitativi più stringenti e aggiornati.
In definitiva, l’acqua del rubinetto rappresenta generalmente una scelta sicura ed economica, a patto di informarsi sulla qualità locale e di non sottovalutare il ruolo delle sostanze chimiche necessarie per la sua potabilizzazione. La ricerca scientifica e la trasparenza degli enti pubblici restano i migliori alleati del consumatore consapevole.